Economia. Come vincere le sfide della globalizzazione
Pelanda:
investire sui cittadini
di Alessandro Bettero
Emergenza occupazione. Crisi delle borse. Qualità della produzione. Giustizia sociale. Nel libero mercato vince chi privilegia il "capitale umano". Obiettivo: lo Stato della crescita.
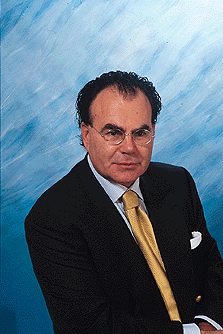 |
"L’Europa non deve seguire necessariamente un modello americano di sviluppo per avere il liberismo e il capitalismo di massa. Nella tradizione europea c’è sempre più Stato, e questo non è un male". Il professor Carlo Pelanda – già consulente scientifico dell’ex segretario dell’Onu, Perez De Cuellar, e tuttora docente di International Futures (Economia e scenari internazionali) e Political Ecology all’Università della Georgia di Athens (Usa) – ha un’idea precisa dei parametri di cui Italia ed Europa devono tenere conto se non vogliono perdere il treno della globalizzazione dell’economia mondiale. Un fenomeno che chiama in causa la fragilità finanziaria dei Paesi emergenti, ma anche le obsolete istituzioni politiche e sociali del vecchio continente. |
"In Europa – osserva Pelanda – c’è l’idea che lo Stato debba proteggere l’individuo invece che investirci sopra per renderlo più competitivo. E il risultato è che la ricchezza dell’Europa emigra altrove mentre aumenta la disoccupazione nel nostro continente; una disoccupazione che è prevista in crescita nel 1999 e nel 2000. Oggi l’economia globale richiede che tutti i Paesi siano competitivi, e la competizione avviene tra chi ha le tasse più basse, la scuola migliore, ecc. In sostanza, laddove l’individuo è messo nelle condizioni di avere un più alto valore di mercato. Purtroppo l’Italia, così come l’Europa, è un po’ indietro. Questo lo si vede nella quantità di disoccupati. In tutta Europa la media dei disoccupati è superiore al 10 per cento. Negli Stati Uniti, invece, la disoccupazione è scesa ultimamente ai minimi storici, cioè al 4,3 per cento!"
Msa. Chi ci guadagna di più, e chi ci rimette, nel mercato
globale?
Pelanda. Negli ultimi 8-9 anni, circa 2 miliardi e mezzo
di persone sono passate da economie comuniste (e quindi isolate dal
mercato internazionale) oppure semplicemente sottosviluppate, all’economia
capitalistica globalizzata. E hanno sicuramente migliorato la loro
condizione economica. Poi, è un discorso più lungo vedere se hanno
migliorato la loro condizione umana. Secondo me, il mercato globale porta
ricchezza a tutti. Bisogna, ovviamente, correggere alcuni aspetti. I
maggiori problemi che abbiamo sia di ingiustizia sociale che di
instabilità finanziaria nel processo turbolento di formazione del mercato
globale, sono caratterizzati fondamentalmente dalla libertà del capitale
di andare dove fa più profitto. Molti problemi nascono perché istituzioni
e Paesi non sono in grado di ricevere questa economia più sofisticata. È
chiaro che per partecipare all’economia globale, un Paese deve avere
sistemi di trasparenza, di controllo di polizia, per evitare dei processi
economici occulti o illegali che creano dei disastri, i quali, a loro
volta, ricadono sulla gente, perché una crisi finanziaria genera una
recessione nell’economia reale.
E la giustizia sociale?
Questo è un tema più delicato. Perché
ogni processo di modernizzazione implica fatica, specialmente nei processi
iniziali di sviluppo capitalistico e di passaggio da una un’economia
rurale a una industriale; implica una fase di sfruttamento e di
ingiustizia. In questo momento non siamo ancora in grado di valutare, per
una questione di tempi, quale sia stata l’evoluzione della condizione
umana dopo i primi sette, otto anni di funzionamento dell’economia globale
in tutto il pianeta.
La crisi delle borse brasiliane può ripetersi ancora, ed espandersi per
"effetto domino" anche ad altri Paesi del Sudamerica, replicando quanto è
già accaduto l’anno scorso sui mercati finanziari asiatici?
Il
pericolo c’è, nel senso che se una grande economia emergente comincia a
svalutare, quelle che sono toccate hanno anch’esse una pressione
svalutativa; per due aspetti: uno pratico, cioè il problema della
competitività delle esportazioni; e uno più psicologico del mercato
finanziario globale: la crisi di un Paese tende a ridurre la fiducia del
mercato in generale sui Paesi emergenti; quindi il mercato tende a
ritirare i propri capitali d’investimento da questi Paesi emergenti. Nel
caso brasiliano la questione della fiducia c’è, ma non è così marcata
com’è stato per la crisi asiatica dell’anno scorso. Possiamo dire che il
mercato globale si è vaccinato contro le crisi di fiducia. Cioè il mercato
comincia a capire che è proprio la sua natura planetaria a creare una
maggiore instabilità. Per cui ci sono meno impatti quando avviene una
crisi di questo tipo.
Mentre Argentina e Brasile sono i Paesi più avanzati del Sudamerica, ce ne sono altri maggiormente in difficoltà. Per esempio il Venezuela che, a prescindere dal disordine interno, ha visto entrare in crisi i bilanci statali, poiché dipende parecchio dalle risorse petrolifere (e il prezzo del petrolio è molto calato). La stessa cosa succede in Messico dove per mantenere il consenso, il governo non può comprimere oltre una certa misura la spesa pubblica, e deve destinare parte di questa a risolvere problemi di base della popolazione, cioè addirittura programmi di alfabetizzazione. Per cui questi Paesi, peraltro anche molto indebitati, sono a rischio continuo di una crisi di sfiducia che porta via loro il capitale e li manda in tilt. Così sono molto esposti e molto vulnerabili alle variazioni che avvengono nella loro area geo-economica.
Da tutto questo si evince un dato negativo: i fatti mostrano come passeranno ancora parecchi anni prima di arrivare a capire come si può dare un minimo di stabilità a questo sistema globale.
L’Italia, così com’è organizzata, riuscirà a sostenere, sul piano
politico, economico e produttivo, le sfide imposte dalla globalizzazione?
Mercato globale significa più concorrenza,
soprattutto sul piano della qualità dell’istruzione, delle merci, dei
processi industriali, della cultura. Per questo ci vorrebbe una politica
che aiutasse di più il mercato nazionale a svilupparsi. L’Italia non ha
modernizzato gli aspetti tecnici delle istituzioni, cioè è ancora uno
stato abbastanza ottocentesco. E, poi, c’è alla guida del Paese una
sinistra che non è "amichevole" nei confronti dei requisiti richiesti
dalla competizione del mercato globale. Questo suo "non essere amichevole"
si vede nei fatti: tiene le tasse molto alte, il che riduce gli
investimenti di capitale; tiene molto rigido il mercato del lavoro: se io
assumo e non posso licenziare, è ovvio che non assumerò nessuno e lo andrò
a fare in altri Paesi che me lo lasciano fare, e questo crea
disoccupazione. Oggi non è più possibile tutelare in forme antiquate la
ricchezza della popolazione.
Per l’Italia, ma anche per altri Paesi europei esistono due fenomeni
correlati da affrontare: quello dell’occupazione e quello del cosiddetto
welfare state. Tra le due alternative: uno stato sociale e un
regime di libero mercato, e quindi di alta mobilità della forza lavoro,
come avviene per esempio negli Usa, quale opzione dovrebbero scegliere
Italia ed Europa per assicurare sviluppo e benessere ai propri
cittadini?
Fondamentalmente occorrerebbe non perdere la natura
sociale dello Stato, perché questo è un bene, ma bisogna trasformare il
concetto di socialità. Al momento lo Stato è sociale perché incentiva il
finanziamento passivo degli individui: cioè sono un cittadino, non ho
voglia di fare cinquanta chilometri per andare a trovare un altro lavoro,
mi dichiaro disoccupato e lo Stato mi dà molti soldi, e questo mi
incentiva ad essere un po’ pigro, oltre a sprecare denaro, il che comporta
l’aumento delle tasse e quindi un danno al mercato privato e alla sua
dinamicità.
Senza perdere il concetto che una comunità deve assicurarsi che un individuo viva il meglio possibile, bisogna però, d’altro canto, costringere gli individui ad essere un po’ più attivi. Per cui la comunità, cioè lo Stato, dice al cittadino: "io ti finanzio, ti aiuto, non ti lascio solo, ti pago un corso di ri-formazione se le tue competenze non sono sufficienti, ti do le risorse affinché tu sia in grado di lavorare meglio, di essere più mobile sia intellettualmente che fisicamente per cercarti un lavoro, per fare la tua vita dignitosa, ecc..., ma tu in cambio mi devi dimostrare che sei più attivo sul piano economico". Si tratta di trasformare il contratto sociale di tipo europeo-continentale, cancellando le garanzie passive, cioè l’assistenzialismo, e trasformarle in garanzie attive. Insomma, i soldi pubblici devono essere finalizzati alla crescita continua del "valore di mercato" dell’individuo. Sull’argomento sto scrivendo un libro: Dallo Stato sociale allo Stato della crescita.